Da sempre gli abitanti dell’arcipelago delle Tuamotu raccoglievano ostriche perlifere. Naturalmente lo facevano quelli dotati di una maggiore capacità polmonare o che comunque riuscivano a stare più a lungo sott’acqua senza respirare. La tecnica era semplice e intelligente: una pietra, assicurata a una cima, consentiva al pescatore - ma forse è più giusto definirlo raccoglitore - una discesa molto veloce e soprattutto con pochissimo consumo di energie. La risalita in superficie, gravata dal peso della pietra, del canestro con le ostriche e del subacqueo più i notevoli attriti, era a carico quasi totale del compagno sull’imbarcazione il quale, a grandi bracciate e alla maggior velocità possibile compiva questa operazione svariate decine di volte al giorno. L’equazione è elementare: più tuffi, più tempo sul fondo, recuperi più rapidi e ottimizzazione dei tempi morti equivalgono a un maggior numero di ostriche raccolte. Con qualche ma. Capitava che qualche tuffatore risalisse accusando qualche strano malessere, non riuscisse a parlare bene, storcesse una parte del volto in una espressione grottesca, non potesse più muovere un braccio o una gamba o tutti e due. Le prime volte avranno riso, gli altri. E avranno battezzato questi comportamenti bizzarri come bizzarri, appunto, provocati chissà da quale sconosciuta forma di pazzia: l’hanno chiamata pazzia, taravana nella loro lingua. Intanto qualcuno ci lasciava le penne, ma le ostriche erano lì, bisognava prenderle (continua sul giornale).
Leggi il prossimo

Blood Shift
L'apnea, per definizione, è l'assenza dell’atto respiratorio o una pausa di esso per un determinato lasso di tempo. Durante l'apnea viene interrotta la respirazione, ma ovviamente non lo scambio gassoso; si ha quindi una progressiva riduzione della concentrazione di ossigeno nell'aria

Zavorre Sub Plastificate Fonderia Roma
Fonderia Roma ha un ampio catalogo di zavorre per la pesca subacquea. Tra queste i pesi plastificati, oltre ad essere anatomici e calibrati nel peso, sono protetti da uno strato plastificato che rende ancor più liscia la superficie e non permette all’acqua di mare di “aggredire” il piombo. Le

La Sindrome del Taravana
Da circa vent’anni a questa parte si parla sempre più spesso di incidenti, nei pescatori subacquei, di una patologia nota come “taravana” che ha coinvolto in particolare gli agonisti di questa disciplina o coloro in grado di operare per parecchie ore a quote me-dio alte, generalmente oltre i 30
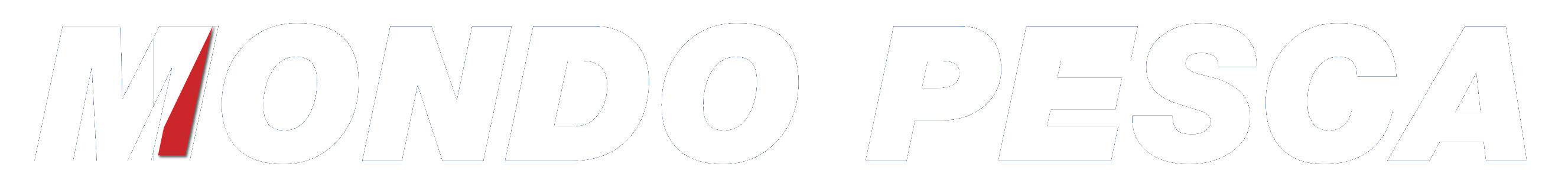

Commenti ()